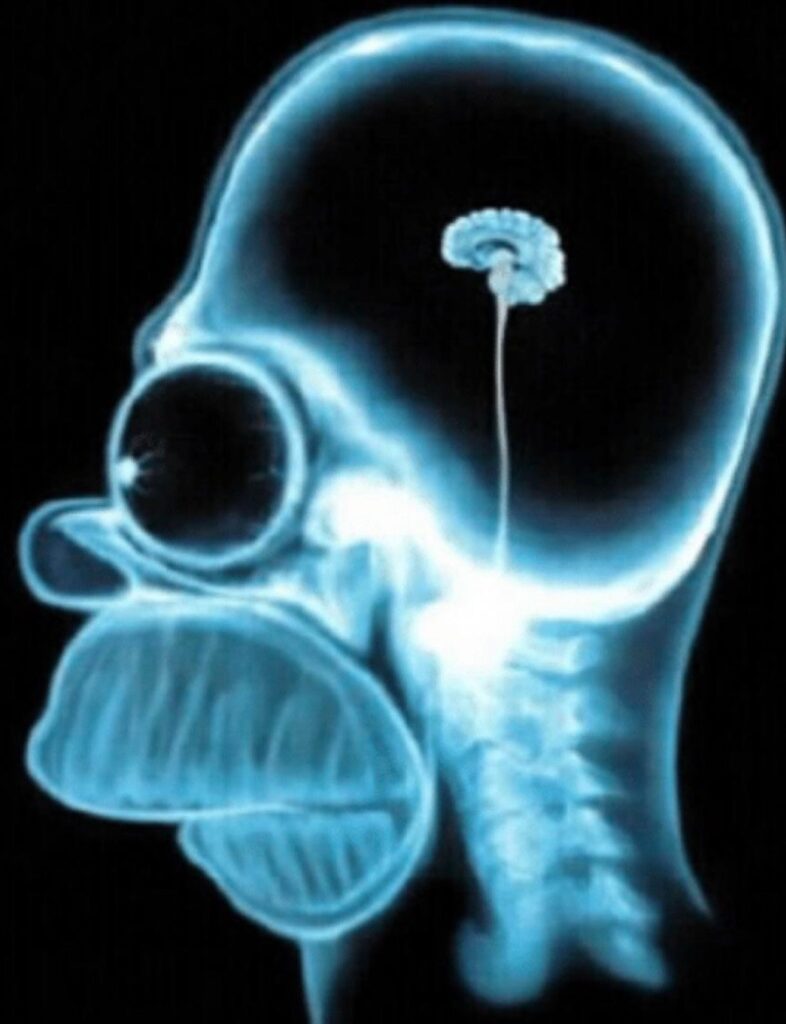
Serve, eccome.
Il nulla cosmico che certi fenomeni dell’apparenza ostentano senza imbarazzo, come fosse il loro lato migliore, anche se i più non sembrano disposti a riconoscerlo, forse timorosi dell’orrida piega evolutiva che potrebbe prendere l’umanità, è a volte utile alle masse: l’esempio è talmente poco edificante, privo di qualità o di virtù, che ognuno si sente, in cuor suo, di poterlo eguagliare e, perché no, battere, anche facendo poco, avendo meno, non potendo, al contrario di quei personaggi, esibire lussi.
È difficile invidiare, tra gli altri, Gianluca Vacchi, anche per chi avrebbe forse motivo di farlo, desiderando molti dei piaceri che egli sfoggia. C’è chi invidia quel lusso ad altri, ma non a lui.
Anzi, tra poveri Vacchi riscuote poca simpatia e nessuna ammirazione… A volte tenerezza per le penose messinscene, risultando celebre più per sue esibite, fossero pure artefatte, tare psicologiche che per il tenore di vita, per le sue qualità o per il suo talento.
Chiunque è sicuro, trovandosi a essere ricco come Vacchi, che saprebbe spendere tutti quei soldi meglio di lui, tanto da dubitare che sarebbe davvero così bello averne e che sia un vanto, e non una cosa di cui vergognarsi, essere così ricchi ma apparire così sciocchi.
Invece, la mostra delle amenità rende un buon servizio all’umanità, perché permette di apprezzare, tanto da contribuire a renderla a loro cara, ogni risorsa, ogni qualità vera o presunta della vita dei molti individui che, in mancanza di ricchezze materiali, vedrebbero una magra consolazione nel disprezzarle, come fa la volpe con l’uva, per dedicarsi a quelle immateriali senza chiedersi se siano, pur nobili, davvero da preferirsi.
In pochi, mi pare, ne tessono le lodi, per cui non guasterà se sarò io a ringraziare Vacchi e gli altri.
Grazie, quindi, a Gianluca Vacchi, a Elettra Lamborghini, a Ivana Trump, a Paris Hilton, a Lapo Elkann, alle Kardashian e a tutti i frutti fermentati dell’apparenza, più che dell’essenza, dell’esibizione come unica prova tangibile di essere esistiti, del superamento di Descartes e persino di Nietzsche.
Essi vivono come noi, infondo.
Amano, tribolano, sperano e disperano, ma preferiscono consegnare all’immortalità indelebili scampoli di eterea vacuità, deiezioni di divina inutilità, invece di fuggevoli frammenti di concretezza, di durevole, fin che dura, mortale umanità.
Meritano gratitudine, per galleggiare allegramente sul mare infinito della loro mancanza di prospettiva, poiché ci permettono di cogliere la vera bellezza delle nostre qualità, quali esse siano, di goderle per quello che sono, anche non fossero realmente gemme preziose e vitali di eccellenza.
Essi sacrificano ogni momento della loro vita, anziché alla ricerca di qualcosa, di una cosa qualsiasi, alla mostra di sé, alla fiera delle proprie vanità, fornendo prova indelebile di ciò che non sanno dire o che non sanno fare, della loro diversamente competente esistenza, pur essendo innegabile che essa somigli, in molte occasioni, a quella di tutti noi e che, lavorandoci, si potrebbe, forse, migliorarla, mostrandoci che c’è qualcosa da salvare, da sviluppare.
Invece, anziché promuovere una qualsiasi potenziale evoluzione, restituendo una dimensione etica al loro ruolo di esempio, accettano di non esserlo affatto, chiarendo definitivamente la differenza tra i loro sterili semi e i nostri, mai sufficientemente apprezzati, se non nel confronto coi primi, germogli di speranza nel progresso dell’umanità, cui noi dedichiamo le nostre esistenze sommerse, perché è nella nostra natura, ma che probabilmente apprezzeremmo di meno, se fossimo obbligati a confrontarci solo con le gesta più meritevoli degli uomini e delle donne che sono migliori di noi.
Sotto la superficie di quel mare amorfo di vite atrofiche, nel profondo, noi, infine, esistiamo, più per quelle che per l’esempio virtuoso dei miti inimitabili di uomini che non saremmo in grado di capire o di seguire a lungo.
Siamo come bambini, che contestano i genitori, ma copiano i fratelli maggiori, esempi più vicini e quindi più comprensibili, in tutto, salvo quando sbagliano. Non capiamo ancora (o non capiamo più) l’eccelsa virtù, la lontana e rarefatta rettitudine degli esempi positivi, ma riconosciamo automaticamente tutti i vizi degli dèi dell’Olimpo. Osserviamo compiaciuti e divertiti la via che non potremmo comunque perseguire e che, grazie a Vacchi, non saremmo più disposti a seguire; riconosciamo i superuomini e le superdonne, che non ci sembrano, in definitiva, poi tali, da vicino e, a torto o a ragione, perseveriamo a volerci distinguere, perlomeno da loro.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.